L’esercito cinese è il più grande del mondo e ha fatto progressi enormi grazie alle riforme introdotte da Xi Jinping, volte a contrastare la corruzione e l’inerzia burocratica. L’intera struttura di comando è stata ridisegnata e modernizzata per rispondere alle necessità della guerra moderna, totalmente dipendente dalle tecnologie all’avanguardia e dall’uso dell’intelligenza artificiale, campo nel quale Pechino ha compiuto significativi passi avanti. A metà del 2024 l’arsenale nucleare cinese comprendeva almeno 600 testate operative e si calcola che entro il 2030 arriverà a più di 1.000. Un passo ulteriore è l’adozione di una politica di fusione militare-civile che promuove il coordinamento e l’integrazione dell’industria civile e militare. Oltre a una capillare presenza economica che si estende a tutti i continenti, il Partito comunista cinese ha ora a disposizione uno strumento potente e moderno per affiancare la sua espansione globale. Non à detto che venga dispiegato ma è una realtà di cui bisogna seriamente tenere conto.
Grazie alla sua costante crescita economica Pechino possiede una poderosa base industriale che le consente di sfornare sistemi d’arma avanzati in tempi molto ristretti. Ha fatto notevoli progressi negli aerei stealth e nelle armi ipersoniche. Per dare un’idea della velocità con cui si muove l’industria bellica cinese basta ricordare che, negli ultimi quattro anni, la Cina ha compiuto più lanci di prova di missili balistici di tutto il resto del mondo. L’arsenale cinese è enorme ed è basato su una crescente quantità di missili balistici e su un numero imprecisato di missili cruise a cui i militari attribuiscono una speciale importanza. Secondo fonti del ministero della Difesa statunitense anche se non ci sono dati sicuri sul numero effettivo di missili balistici, è stato calcolato che tra il 2016 e il 2022 il numero di missili intercontinentali è aumentato intorno al 200 per cento. Tra i vari modelli spicca il DF-17 molto più pericoloso di un missile balistico tradizionale poiché possiede capacità HGV (in grado di manovrare e planare a velocità supersonica) e può superare la velocità di Mach 5.
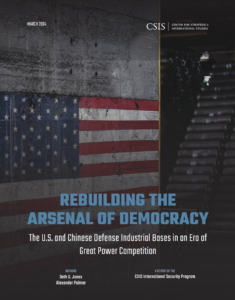
Secondo uno studio del 2023 la Cina metterà in campo tra 108 e 144 lanciatori di DF-17 entro il 2028, aumentando in modo esponenziale il numero di sistemi HGV attivi realizzati negli ultimi cinque anni. Gli Stati Uniti stanno invece mostrando qualche difficoltà nei missili ipersonici, visto che nessuno dei prototipi previsti nel 2023 è stato effettivamente dispiegato. È possibile che questo ritardo dipenda non tanto dall’inferiorità industriale quanto dalla ricerca di caratteristiche ancora più ambiziose, ma non ci sono dubbi che la modernizzazione cinese rimanga una minaccia per la libertà di azione statunitense. I dati, con qualche integrazione, sono desunti dallo studio del Center for Strategic and International Studies (CSIS) citato nella seconda parte di questa serie di articoli.
Esercito e aeronautica
Le forze armate cinesi, denominate Esercito di liberazione popolare (Elp), posseggono il più grande esercito di terra del mondo. Il numero degli effettivi arriva al milione, ma il totale di tutte le forze armate è di 2.545.000 con le riserve, con 75 divisioni (gli USA, includendo le riserve, ne hanno 24) e 4.700 carri armati da combattimento (USA, 2.740). Anche se negli ultimi cinque anni non è molto aumentato di dimensioni si è dotato di più armamenti pesanti, aggiungendo nove brigate corazzate e riducendo il numero delle brigate di fanteria leggera e meccanizzata. Il 70 per cento dei carri armati da combattimento è moderno e più del 60 per cento delle brigate corazzate è equipaggiato con veicoli avanzati. La cosa importante è che questi veicoli sono di fabbricazione cinese e mostrano chiaramente che Pechino intende allontanarsi dall’aspetto quantitativo per puntare su quello qualitativo.
Una delle dotazioni più importanti è il PCH191, una lanciarazzi multiplo, un sistema modulare capace di operare con diversi tipi di razzi. Questo sistema d’arma è in grado di lanciare razzi a basso costo, missili cruise antinave e missili d’attacco terra-terra. Secondo gli analisti, gli attacchi missilistici di precisione a lungo raggio e la capacità di questi sistemi d’arma di colpire anche le navi consentiranno alle unità che ne sono dotate di giocare un ruolo importante in una ipotetica invasione di Taiwan, con una notevole potenza di fuoco rivolta contro l’isola e contro le navi che operano nello stretto. Il prezzo relativamente basso dei missili usati potrebbe inoltre dare a queste unità un ruolo centrale in un conflitto prolungato che coinvolga forze di terra. Anche se le capacità belliche di un esercito sono definite dal livello di addestramento e dalla tecnologia militare utilizzata, l’invasione dell’Ucraina (attentamente studiata dagli strateghi cinesi) dimostra come anche l’aspetto quantitativo abbia una sua importanza centrale. Le grandi dimensioni dell’esercito cinese rimangono un asso nella manica nel caso di un conflitto prolungato.
L’aeronautica cinese ha oggi in dotazione circa 2.250 caccia da combattimento, in crescita rispetto ai 2.120 di dieci anni fa. Alla fine del 2016 circa 800 velivoli da combattimento appartenevano alla quarta e quinta generazione, ma alla fine del 2023 il numero era arrivato a 1.500. La Cina ha anche prodotto almeno 200 J-20, un caccia da combattimento di quinta generazione e sta progressivamente accelerando nella produzione di questi velivoli. Questo numeri sono ancora inferiori a quelli dell’aeronautica USA, che ha in dotazione più di 3.300 caccia di quarta e quinta generazione ma, nondimeno, danno un’immagine efficace del grande tasso di produzione di questi velivoli avanzati. Gli Stati Uniti mantengono ancora un grande vantaggio nel numero dei caccia di quinta generazione, avendo a disposizione 166 F-22 e ben 606 F-35, considerati i jet da combattimento più avanzati al mondo. Esiste ancora una notevole differenza tra le dotazioni dell’aviazione statunitense, ma l’industria cinese sta progressivamente riducendo il gap che la separa dal suo avversario americano.

Valutazioni discordanti
Washington spende per la difesa quasi il triplo di Pechino (877 miliardi di dollari, contro 292), ma vista la tendenza attuale, sarà probabilmente costretto ad aumentare ulteriormente gli investimenti. Durante la Guerra fredda il bilancio della difesa rappresentava tra 9 e l’11 per cento del Pil con l’amministrazione Eisenhower, tra l’8 e il 9 per cento con le amministrazioni Kennedy e Johnson e più del 6 per vento con l’amministrazione Reagan. Oggi è circa il 3,50 per cento mentre il bilancio di Pechino è l’1,60 del Pil. Il citato rapporto del CSIS ritiene che «una parte significativa del problema è che il sistema di difesa degli USA agisce come se fossimo in un periodo di pace, nonostante una guerra protratta in Ucraina, una guerra in corso in Medio Oriente e tensioni crescenti nell’Indo-Pacifico e in aree come lo Stretto di Taiwan e la Penisola coreana».
Nell’analizzare le capacità produttive cinesi il rapporto afferma che «la base industriale per la difesa della Cina sta agendo come se fosse in un periodo di guerra, si sta sviluppando velocemente, è in grado di produrre sistemi d’arma e si sta preparando a combattere una guerra contro un’altra grande potenza, in modo particolare gli Stati Uniti. Le guerre combattute tra grandi potenze sono state vinte storicamente da quelle nazioni o da quelle coalizioni che riescono a costruire, spendere, mobilitare e combattere più dei loro avversari. Sia la storia moderna che la guerra in corso in Ucraina dimostrano che la capacità di produrre più armi ed equipaggiamenti è cruciale per un Paese in guerra. Non ci sono ragioni per credere che una guerra tra Cina e Stati Uniti sarebbe diversa e le forze relative delle loro basi industriali per la difesa sono perciò un fattore chiave in un confronto strategico».
Anche se esamina con accuratezza tutta una serie di carenze dello sforzo bellico cinese, il rapporto del CSIS giunge a conclusioni molto drastiche, che non sono però condivise da tutti gli analisti. Uno studio del 27 gennaio 2025, redatto da Timothy Heath per conto della Rand Corporation di Washington, fa un’analisi molto diversa e afferma che l’esercito del gigante asiatico «al momento non è pronto per la guerra». Secondo Heath, la vera vocazione dell’Elp è «di mantenere la presa sulla società cinese», consentendo al Partito comunista di mantenere il controllo assoluto sulla società e non di «combattere un nemico d’oltremare». Le valutazioni sono basaste sulla storia del Partito comunista e sul suo stretto rapporto con l’esercito, grazie al quale furono sconfitti i nazionalisti di Chiang Kai-shek. Il rapporto ritiene inoltre che i problemi economici attuali della Cina (bolla immobiliare, crisi demografica e forte disoccupazione giovanile) peggioreranno ulteriormente e quindi l’esercito sarà spinto ancora di più a concentrarsi sul controllo interno, piuttosto che rischiare una guerra su larga scala e ad alta intensità.
Ma il rapporto della Rand sembra trascurare la profondità della riforma strutturale introdotta di Xi Jinping nel 2016 che ha profondamente svecchiato l’Elp consentendogli di poter operare a livello interforze, requisito essenziale per combattere le guerre moderne. In pratica, la Cina ha deciso di compiere quello che il governo USA ha valutato come «un passo senza precedenti per facilitare l’entrata di imprese private nella base industriale del sistema della difesa». Quell’analisi governativa identificava 183 imprese private che hanno fornito beni o servizi all’aeronautica militare e al settore aerospaziale. Tra queste, ben 108 avevano legami con il Partito comunista cinese o con l’esercito e questo consentiva loro delle facilitazioni che non sono alla portata delle normali imprese commerciali.
Ben presto sono arrivati importanti risultati come la trasformazione della marina nella più grande del mondo, grandi progressi nella costruzione di caccia avanzati e missili molto competitivi rispetto a quelli degli USA. È però vero che il più grande esercito del mondo si dibatte in un grande paradosso. Come ha spiegato all’Avvenire il 28 febbraio 2025 Simone Dossi, professore associato di Relazioni internazionali all’Università Statale di Milano, «la Repubblica popolare è stata frequentemente e intensamente coinvolta in guerre nei suoi primi trent’anni di vita, ma non ha più combattuto guerre dopo quella contro il Vietnam del 1979 e i suoi strascichi negli anni Ottanta. L’Epl non combatte una guerra da 40 anni e questo non può non avere conseguenze sul suo livello di preparazione, a maggior ragione se teniamo conto delle straordinarie trasformazioni che la guerra ha attraversato in questi quattro decenni».
Gli equilibri militari nel Mar Cinese Meridionale sono profondamente cambiati a favore di Pechino, come è ampiamente dimostrato dalle esercitazioni navali nello Stretto e dai sorvoli aerei su Taiwan che sono ormai diventati routine. Mentre fino a trent’anni fa Pechino si limitava a intimidire l’isola ribelle, la situazione è profondamente cambiata e le forze cinesi sono perfettamente in grado di lanciare una serie di operazioni su larga scala, tra cui un’invasione, una campagna di attacchi missilistici o un blocco navale di Taiwan. Dosssi conclude che «l’Asia orientale marittima è la vera linea di faglia della competizione tra Cina e Usa. Qui Pechino ha interessi nazionali cruciali, a partire proprio da Taiwan, particolarmente sensibile per Pechino anche per ragioni di legittimità interna. In questa stessa regione, e non in Europa né in Medio Oriente, gli Stati Uniti si giocano il futuro della propria egemonia globale. Uno scontro diretto tra Cina e Stati Uniti avrebbe implicazioni sistemiche di gran lunga superiori rispetto a quelle della guerra in Ucraina. Il vero rischio è appunto questo: che una scintilla nei mari dell’Asia orientale possa innescare un conflitto potenzialmente generale, tale da travolgere l’intero sistema».
Anche se non ci sono studi specifici sul possibile ruolo militare delle numerose comunità cinesi

presenti in tutto il mondo, non si può ignorare che ci sono decine di milioni di cinesi che vivono in Occidente e mantengono legami molto stretti con la madrepatria. Sono stati lanciati diversi allarmi sulla funzione degli Istituti Confucio presenti in tutto il mondo nel raccogliere informazioni sui Paesi che li ospitano. Senza contare che in tutti i Paesi dove sono presenti comunità cinesi operano migliaia di “commissariati informali” gestiti da personale cinese con lo scopo ufficiale di aiutare i connazionali nelle pratiche burocratiche, ma che si sono rivelati strumenti per schedare o, addirittura, rimpatriare gli oppositori politici del Partito comunista. Senza contare i miliardi di dati che i servizi segreti cinesi raccolgono attraverso popolari app come TikTok o le reti di telecomunicazioni operate da gestori cinesi che mantengono stretti contatti con il loro governo. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che alcune delle principali società di posa e riparazione di cavi sottomarini, che rappresentano il cuore delle comunicazioni mondiali, sono cinesi e che durante le operazioni di riparazione è possibile inserire una “porta” attraverso cui carpire informazioni preziose. Bisogna quindi essere molto cauti nel trattare l’esercito di Pechino come un elefante burocratizzato che si muove con difficoltà nel rutilante mondo moderno.
Niente è scritto
Come ha dimostrato lo studioso giapponese Koichiro Takagi, Pechino ha fatto molti progressi nella cosiddetta “guerra cognitiva”, la frontiera avanzata delle guerre del futuro ma, nonostante i prodigiosi successi economici colti nei decenni passati, ci sono ancora una serie di punti critici che affliggono la Cina, come ha messo bene in evidenza il rapporto del CSIS citato. L’industria della difesa cinese è senz’altro poderosa ma presenta almeno quattro debolezze: una dipendenza eccessiva dalle importazioni dall’estero, una carenza nella standardizzazione dei sistemi, una corruzione molto diffusa e la mancanza di alleati e partner. Pechino dipende inoltre dai circuiti integrati che hanno un doppio uso civile e militare e sono esportati da USA, Giappone, Corea del sud e Taiwan. Anche se sono esportatori a loro volta, i chip cinesi sono di qualità inferiore a quelli occidentali, soprattutto per quelli ad alta efficienza.
Un altro punto debole è rappresentato dalla necessità di importare macchine utensili complesse dall’estero perché quelle prodotte in Cina non sono di qualità adeguata per settori avanzati come l’industria aerospaziale. Anche in questo caso, le macchine utensili importate dalla Cina provengono da Paesi alleati degli USA come Germania e, ancora una volta, Giappone, Corea del sud e Taiwan. Dulcis in fundo, l’esercito cinese mostra una grande difficoltà operativa nel tradurre nella pratica le capacità difensive e, soprattutto, soffre di quella che è stata definita “malattia della pace”, la già ricordata mancanza di esperienze di combattimento, visto che l’ultima guerra combattuta dalla Cina risale al conflitto con il Vietnam del 1979. I soldati, l’equipaggiamento e la dottrina militare non sono stati testati sul campo di battaglia. Certo, la marina e le truppe da sbarco di Pechino diedero una buona prova di sé durante la guerra civile libica che portò alla caduta di Gheddafi nel 2011, riuscendo a radunare e portare in salvo quasi 20.000 cittadini cinesi che lavoravano nel Paese. Ma anche le ripetute operazioni di peace keeping per conto dell’ONU non sono confrontabili con le esperienze sul campo di battaglia, come ha significativamente illustrato il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina.
Non stiamo marciando come zombie verso un conflitto inevitabile e non è detto che la “trappola di Tucidide” sia destinata a ripetersi meccanicamente. Non dobbiamo dimenticare però che da circa vent’anni il Dragone ha una capillare presenza nelle strutture portuali e commerciali del mondo e, per quanto riguarda l’Africa, una posizione di assoluto predominio che non è stata minimamente intaccata da nessun’altra potenza. In numerosi discorsi ufficiali Xi Jinping non ha nascosto l’aspirazione cinese di ricoprire una posizione centrale in un nuovo ordine globale e per raggiungere questo obiettivo intende applicare la linea elaborata da Sun Tzu, autore dell’Arte della guerra, un antico trattato di strategia militare in cui sosteneva che «ottenere cento vittorie su cento battaglie non è il massimo dell’abilità: vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo». Non è detto che il secondo esercito del mondo dopo quello degli Stati Uniti entri mai in azione ma può sicuramente contare sulla politica erratica e divisiva dell’amministrazione Trump e sulla totale inconsistenza dell’Europa che, pur nella drammaticità del momento attuale, si sta rivelando ancora una volta incapace di prendere decisioni strategiche. (fine)
Galliano Maria Speri
